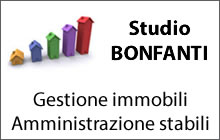Airuno: riti, usanze, credenze per raccontare “sorella morte”. Dalle confraternite al “fiocco” fino alle agonie differenziate
Un evento biologico che veniva vissuto con serenità, celebrato con la partecipazione dell'intero paese e attraverso riti e tradizioni che in gran parte si sono persi nel tempo. È la morte, che oggi spaventa e angoscia ma che nei decenni tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta era parte integrante della vita comunitaria dei paesi della Brianza lecchese.
Una vita caratterizzata dalla povertà, che ruotava intorno all'attività agricola nei campi, dove malattie oggi curabili ponevano fine all'esistenza fin dalla più tenera età. Grazie alla Pro loco di Airuno, che da anni cura l'"Archivio della memoria" del paese, tradizioni e usanze legate alla sepoltura dei defunti sono state raccontate in sala consigliare, nella serata promossa dall'associazione giovedì 6 novembre.
A commentare le immagini in bianco e nero e i documenti uscite dalle cantine e dalle soffitte del paese, oltre al presidente Rita Mauri, il professor Carlo Gilardi che è anche autore di una serie di poesie "a tema" lette durante la serata.
"Un tempo la morte era vissuta in modo naturale, quasi un sollievo dalle tribolazioni della vita vissuta" ha spiegato il professore. "Tante erano le credenze intorno ad essa, come l'idea che alcuni oggetti o animali come la civetta ne fossero presagi".
Il testamento veniva sottoscritto per dare indicazioni precise sul funerale e le celebrazioni successive. In uno scritto datato 1889 e proveniente da Aizurro, un uomo così scriveva: "Lascio che mi sia fatto il funerale di numero 12 sacerdoti, compreso il parroco, e che mi siano celebrate numero 10 messe nel periodo di due mesi dopo la mia morte. Una messa si faccia celebrare all'anniversario del giorno della morte fintanto che esistono i miei figli. Questa è la mia buona volontà ultima, che voglio adempita in ogni sua parte".
I funerali infatti in quei decenni prevedevano la partecipazione di 12, 8 o 4 sacerdoti, a seconda della ricchezza della famiglia del defunto. "Questo comportava discriminazioni di carattere sociale tra i cittadini, che ora sono fortunatamente scomparse" ha spiegato il professor Gilardi. "Il sacrestano doveva darsi un gran da fare per raggiungere, a piedi o in bicicletta, i sacerdoti dei paesi vicini e chiedergli di partecipare. Se non ce n'erano disponibili a sufficienza chiedeva aiuto ai frati di Sabbioncello, o andava a Lecco in treno".
Al sopraggiungere della morte, che il più delle volte veniva celebrata nella serenità della famiglia e delle mura domestiche, il parroco del paese raggiungeva l'abitazione per i sacramenti e l'estrema unzione. La salma veniva lavata e vestita con l'abito migliore, e adagiata sul letto senza scarpe. Era usanza, e l'immagine della nonna materna del professor Gilardi venuta a mancare nel 1960 ancora ne reca testimonianza, che attorno ad essa venissero disposte delle frasche sempreverdi.
L'annuncio al paese arrivava attraverso le campane. "Non c'erano telefoni allora, fino agli anni Quaranta Airuno aveva 1200 abitanti circa, tutti si conoscevano" ha spiegato il professore airunese. "L'agonia breve indicava che era morto un uomo, se era lunga era una donna. Tutti quindi si recavano in visita all'abitazione del defunto, e le famiglie più abbienti inviavano telegrammi o biglietti listati a lutto per comunicare ai parenti la loro perdita".
Il funerale seguiva riti e tradizioni ben precise, e a seconda di quanto una famiglia poteva pagare i cortei erano caratterizzati dalla presenza dei bambini delle scuole del paese, unitamente ad una serie di "confraternite", come le Figlie di Maria e gli affiliati del Santissimo Sacramento.
Don Gaetano Solaro
"Nel corso dei decenni le divise cambiavano, negli anni Trenta in pieno periodo fascista le "piccole italiane", i "piccoli avanguardisti" e i balilla partecipavano ai funerali" ha spiegato Rita Mauri. "Nel 1936 Don Gaetano Solaro morì a seguito di un incidente, e al suo funerale partecipò l'intero paese compresi i "luigini", le Figlie di Maria, i bambini dell'asilo con i loro mazzi di fiori, le istituzioni".
I bambini, anche nei periodi invernali, andavano in giro in calzoncini corti e dopo la celebrazione in chiesa con tutti i sacerdoti (in genere la bara era posta su un catafalco con ornamenti in velluto) il corteo si avviava al cimitero. "Era Tumasin de Tatu, dal nome del padre Adeodato, a intonare il Miserere in latino" ha spiegato il professor Gilardi. "Una volta giunti al campo santo, con uno solo dei 12 sacerdoti, si recitavano le preghiere e la cassa veniva posta nella fossa scavata a mano. Ognuno raccoglieva un pugno di terra, lo baciava e lo buttava dentro di essa".
A portare la bara a spalla erano in genere i contadini, e nel caso di infanti morti il compito era affidato a bambini intorno ai 10 anni. Al termine della cerimonia la famiglia era solita invitare gli adulti all'osteria per offrirgli da bere per il servizio prestato.
"C'era anche la tradizione del "fiocco", striscia di tessuto collegata al feretro che veniva tenuta da parenti prossimi o istituzioni in caso di funerali importanti come quello di Don Gaetano Solaro. Era un segno di amore e amicizia nei confronti del morto. C'era poi chi aveva in carico di tessere le lodi del defunto, ad esempio Maria Crippa moglie del "Pintarela" per poter guadagnare qualche soldo. I parenti dovevano per un anno osservare il lutto: le donne vestite di nero, gli uomini con un bottone nero appuntato sulla giacca".
Immagini e documenti unici della cultura religiosa che ruotava intorno alla morte dei cittadini sono ora conservati nell'Archivio della Memoria di Airuno, un patrimonio storico che grazie alla Pro Loco continua ad arricchirsi.

Il Professor Carlo Gilardi
Una vita caratterizzata dalla povertà, che ruotava intorno all'attività agricola nei campi, dove malattie oggi curabili ponevano fine all'esistenza fin dalla più tenera età. Grazie alla Pro loco di Airuno, che da anni cura l'"Archivio della memoria" del paese, tradizioni e usanze legate alla sepoltura dei defunti sono state raccontate in sala consigliare, nella serata promossa dall'associazione giovedì 6 novembre.

A commentare le immagini in bianco e nero e i documenti uscite dalle cantine e dalle soffitte del paese, oltre al presidente Rita Mauri, il professor Carlo Gilardi che è anche autore di una serie di poesie "a tema" lette durante la serata.
"Un tempo la morte era vissuta in modo naturale, quasi un sollievo dalle tribolazioni della vita vissuta" ha spiegato il professore. "Tante erano le credenze intorno ad essa, come l'idea che alcuni oggetti o animali come la civetta ne fossero presagi".
Il testamento veniva sottoscritto per dare indicazioni precise sul funerale e le celebrazioni successive. In uno scritto datato 1889 e proveniente da Aizurro, un uomo così scriveva: "Lascio che mi sia fatto il funerale di numero 12 sacerdoti, compreso il parroco, e che mi siano celebrate numero 10 messe nel periodo di due mesi dopo la mia morte. Una messa si faccia celebrare all'anniversario del giorno della morte fintanto che esistono i miei figli. Questa è la mia buona volontà ultima, che voglio adempita in ogni sua parte".

I funerali infatti in quei decenni prevedevano la partecipazione di 12, 8 o 4 sacerdoti, a seconda della ricchezza della famiglia del defunto. "Questo comportava discriminazioni di carattere sociale tra i cittadini, che ora sono fortunatamente scomparse" ha spiegato il professor Gilardi. "Il sacrestano doveva darsi un gran da fare per raggiungere, a piedi o in bicicletta, i sacerdoti dei paesi vicini e chiedergli di partecipare. Se non ce n'erano disponibili a sufficienza chiedeva aiuto ai frati di Sabbioncello, o andava a Lecco in treno".

Il funerale di Don Gaetano Solaro, cappellano della chiesa di Aizurro dal 1901 ai primi mesi del 1923,
parroco di Airuno dal 15 luglio 1923 (ingresso ufficiale) al 15 giugno 1936
parroco di Airuno dal 15 luglio 1923 (ingresso ufficiale) al 15 giugno 1936
Al sopraggiungere della morte, che il più delle volte veniva celebrata nella serenità della famiglia e delle mura domestiche, il parroco del paese raggiungeva l'abitazione per i sacramenti e l'estrema unzione. La salma veniva lavata e vestita con l'abito migliore, e adagiata sul letto senza scarpe. Era usanza, e l'immagine della nonna materna del professor Gilardi venuta a mancare nel 1960 ancora ne reca testimonianza, che attorno ad essa venissero disposte delle frasche sempreverdi.
VIDEO
L'annuncio al paese arrivava attraverso le campane. "Non c'erano telefoni allora, fino agli anni Quaranta Airuno aveva 1200 abitanti circa, tutti si conoscevano" ha spiegato il professore airunese. "L'agonia breve indicava che era morto un uomo, se era lunga era una donna. Tutti quindi si recavano in visita all'abitazione del defunto, e le famiglie più abbienti inviavano telegrammi o biglietti listati a lutto per comunicare ai parenti la loro perdita".
Il funerale seguiva riti e tradizioni ben precise, e a seconda di quanto una famiglia poteva pagare i cortei erano caratterizzati dalla presenza dei bambini delle scuole del paese, unitamente ad una serie di "confraternite", come le Figlie di Maria e gli affiliati del Santissimo Sacramento.

Don Gaetano Solaro
"Nel corso dei decenni le divise cambiavano, negli anni Trenta in pieno periodo fascista le "piccole italiane", i "piccoli avanguardisti" e i balilla partecipavano ai funerali" ha spiegato Rita Mauri. "Nel 1936 Don Gaetano Solaro morì a seguito di un incidente, e al suo funerale partecipò l'intero paese compresi i "luigini", le Figlie di Maria, i bambini dell'asilo con i loro mazzi di fiori, le istituzioni".
I bambini, anche nei periodi invernali, andavano in giro in calzoncini corti e dopo la celebrazione in chiesa con tutti i sacerdoti (in genere la bara era posta su un catafalco con ornamenti in velluto) il corteo si avviava al cimitero. "Era Tumasin de Tatu, dal nome del padre Adeodato, a intonare il Miserere in latino" ha spiegato il professor Gilardi. "Una volta giunti al campo santo, con uno solo dei 12 sacerdoti, si recitavano le preghiere e la cassa veniva posta nella fossa scavata a mano. Ognuno raccoglieva un pugno di terra, lo baciava e lo buttava dentro di essa".
A portare la bara a spalla erano in genere i contadini, e nel caso di infanti morti il compito era affidato a bambini intorno ai 10 anni. Al termine della cerimonia la famiglia era solita invitare gli adulti all'osteria per offrirgli da bere per il servizio prestato.

La nonna del professor Gilardi, composta in casa dopo la morte
"C'era anche la tradizione del "fiocco", striscia di tessuto collegata al feretro che veniva tenuta da parenti prossimi o istituzioni in caso di funerali importanti come quello di Don Gaetano Solaro. Era un segno di amore e amicizia nei confronti del morto. C'era poi chi aveva in carico di tessere le lodi del defunto, ad esempio Maria Crippa moglie del "Pintarela" per poter guadagnare qualche soldo. I parenti dovevano per un anno osservare il lutto: le donne vestite di nero, gli uomini con un bottone nero appuntato sulla giacca".
Immagini e documenti unici della cultura religiosa che ruotava intorno alla morte dei cittadini sono ora conservati nell'Archivio della Memoria di Airuno, un patrimonio storico che grazie alla Pro Loco continua ad arricchirsi.