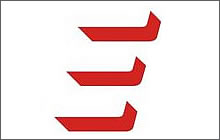Church Pocket/99. La solitudine di don Alberto nel libro “La scelta” cronaca di una frattura annunciata
Non da soli: la vocazione, l’algoritmo e il prezzo della solitudine
C’è una frase che torna, quando un prete decide di non essere più soltanto “un prete”: “Ragazzi, vi devo parlare.” È la frase che apre una porta e, insieme, fa tremare le pareti. Perché quel “vi devo parlare” non è mai solo comunicazione: è una consegna. È un uomo che, finalmente, smette di reggere da solo un’immagine. Nel libro La scelta, Don Alberto Ravagnani racconta anche questo: il momento in cui l’apparato non basta più a contenere la vita. E lo dice in modo spietatamente semplice: «Questi paramenti non riescono più a contenere la mia umanità. Questo ruolo non riesce più a portare la mia fede». Non è una polemica contro la Chiesa in quanto tale; è un referto clinico su una frattura interna. Quando la forma non regge più il contenuto, la forma diventa gabbia. E, prima o poi, o si rompe la gabbia o si rompe l’uomo. Il punto, però, è che la crisi di Ravagnani non si presenta con l’estetica “da crisi”: niente abisso romantico, niente poesia facile. Anzi: l’apertura del libro è quasi da thriller, con le campane che esplodono e l’ansia che ti afferra per il collo: «Cazzo, la Messa!». Un incipit brutale perché è quotidiano. È lì che capisci la natura del problema: non stiamo parlando di un’idea, stiamo parlando di una vita concreta che inciampa su un dovere sacro, e di un sacro che non riesce più a essere casa. Sabato 31 gennaio, memoria di San Giovanni Bosco, Don Alberto sceglie il suo “cortile” di questi anni: i social. Pubblica un video sobrio, quasi riassuntivo. Poche ore dopo, però, la vicenda rientra nella forma istituzionale: una comunicazione ufficiale della Diocesi di Milano, firmata dal Vicario generale mons. Franco Agnesi, informa che Ravagnani ha chiesto di sospendere il ministero presbiterale e che, da quel giorno, non svolge più l’incarico a San Gottardo al Corso né la collaborazione con la Pastorale giovanile diocesana. Inizialmente non avrei voluto scrivere né dire nulla su questa storia. Non per pudore liturgico o per un astratto “senso del sacro”: semplicemente perché scelte di questo tipo si portano dietro, e dentro, molti piani e molte sfaccettature che talvolta risultano chiare solo a distanza di giorni, mesi, anni. E chi meglio di me può saperlo, avendolo vissuto sulla mia pelle. Poi sono arrivate le sollecitazioni di amici, conoscenti e lettori. Allora ho deciso di farlo a modo mio: non nel registro con cui parlavo di Francesco, per intenderci. Prima di scrivere qualsiasi cosa, ho scelto di rivedere alcuni suoi video e di leggere il suo ultimo libro, La scelta, per provare – nei limiti del possibile – a collocare questa decisione dentro il percorso di un uomo, quasi mio coetaneo: di un cristiano, di un seminarista, di un prete che, in fin dei conti, ha compiuto la mia stessa scelta. Queste decisioni assomigliano spesso a operazioni matematiche: a parità di risultato, ci si può arrivare per strade diverse, con metodi e passaggi differenti. Per questo ho scelto di leggerla dentro la sua storia, provando a vedere l’uomo, il cristiano e il prete, prima ancora del personaggio.
Sabato 31 gennaio, memoria di San Giovanni Bosco, Don Alberto sceglie il suo “cortile” di questi anni: i social. Pubblica un video sobrio, quasi riassuntivo. Poche ore dopo, però, la vicenda rientra nella forma istituzionale: una comunicazione ufficiale della Diocesi di Milano, firmata dal Vicario generale mons. Franco Agnesi, informa che Ravagnani ha chiesto di sospendere il ministero presbiterale e che, da quel giorno, non svolge più l’incarico a San Gottardo al Corso né la collaborazione con la Pastorale giovanile diocesana. Inizialmente non avrei voluto scrivere né dire nulla su questa storia. Non per pudore liturgico o per un astratto “senso del sacro”: semplicemente perché scelte di questo tipo si portano dietro, e dentro, molti piani e molte sfaccettature che talvolta risultano chiare solo a distanza di giorni, mesi, anni. E chi meglio di me può saperlo, avendolo vissuto sulla mia pelle. Poi sono arrivate le sollecitazioni di amici, conoscenti e lettori. Allora ho deciso di farlo a modo mio: non nel registro con cui parlavo di Francesco, per intenderci. Prima di scrivere qualsiasi cosa, ho scelto di rivedere alcuni suoi video e di leggere il suo ultimo libro, La scelta, per provare – nei limiti del possibile – a collocare questa decisione dentro il percorso di un uomo, quasi mio coetaneo: di un cristiano, di un seminarista, di un prete che, in fin dei conti, ha compiuto la mia stessa scelta. Queste decisioni assomigliano spesso a operazioni matematiche: a parità di risultato, ci si può arrivare per strade diverse, con metodi e passaggi differenti. Per questo ho scelto di leggerla dentro la sua storia, provando a vedere l’uomo, il cristiano e il prete, prima ancora del personaggio.
Il cuore del libro, però, non è la polemica. È la solitudine. Ed è qui che mi sono sentito vicino all’ex presbitero. Non la solitudine “romantica”, ma quella strutturale: la solitudine di chi deve essere sempre all’altezza di un ruolo e, nel frattempo, resta un uomo. Ravagnani accenna a questo con un tono quasi paterno quando dice che, per molti, «diventare preti per sempre» spaventa. Quella formula è splendida in teologia e difficile nella psiche. Quando la comprendi fino in fondo ti fa paura. Perché il vincolo del matrimonio, per quanto totale, è “finché morte non vi separi”; l’ordinazione porta addosso la grammatica dell’assoluto: «Il Signore ha giurato e non si pente: “Tu sei sacerdote per sempre secondo l’ordine di Melchìsedek”» (Sal 110,4). La promessa è assoluta, mentre la persona è un continuo divenire, come un fiume che scorre nel suo letto. E quando il divenire viene trattato come infedeltà, allora la crisi non trova luoghi dove respirare. Qui non sono riuscito a leggere questa storia in maniera distaccata, algida, cronistica. Ho sentito risonanze troppo vicine per trattare tutto come una notizia. Venerdì sera le lacrime mi hanno solcato il viso: non per una “celebrità” dei social, ma per un uomo. Perché dietro questa storia, prima del clamore e dopo il clamore, resta sempre la stessa domanda nuda: è possibile essere prete senza smettere di essere umano?

Sì, è possibile. Ma non da soli. E questa è la parte che fa più male, perché nel modello che abbiamo ereditato la solitudine è spesso presentata come un prezzo “normale”, quasi un pedaggio inevitabile della vocazione. Ravagnani, invece, la chiama per quello che è: non un accessorio, ma un rischio. Un rischio spirituale e umano insieme. Nel libro, a un certo punto, il discorso scivola su una cosa che nella pratica ecclesiastica viene sempre evocata e raramente costruita: l’amicizia tra preti. Non la cordialità, non la fraternità da foto di gruppo, ma l’amicizia vera, quella che regge il peso dei giorni storti. E lì arriva una frase che, detta da un presbitero, suona come una diagnosi: siamo troppo preti per essere amici. Troppo identificati nel ruolo per permetterci la reciprocità, l’autenticità, perfino il diritto di non essere sempre “all’altezza”. Perché il punto non è avere gente attorno. Il punto è poter essere visti. E essere visti non come funzione, non come “don”, non come immagine pubblica da difendere, ma come persona. Quando il ruolo diventa totalizzante, qualunque cedimento ti appare come tradimento; qualunque fragilità, come scandalo; qualunque stanchezza, come colpa. A quel punto non sei più un uomo che prega: sei un uomo che si controlla. E un uomo che si controlla troppo, prima o poi, implode.
E allora la domanda cambia leggermente forma. Non è più solo: “posso essere prete senza smettere di essere umano?”. Diventa: “chi mi permette di restare umano mentre sono prete?”. Chi mi lascia spazio per avere paura senza essere giudicato? Chi mi ascolta senza trasformare tutto in pratica da archivio? Chi mi sta accanto senza chiedermi di essere, sempre e comunque, un esempio?
Se vogliamo essere onesti, la questione non riguarda soltanto Ravagnani. Riguarda un modo di intendere il ministero. Un sistema che chiede molto e, a volte, accompagna poco. E per questo la storia, letta dentro la categoria della solitudine, smette di essere un caso mediatico e diventa un avvertimento ecclesiale. Perché la solitudine non è neutra: o la attraversi con relazioni vere, oppure ti divora. E quando ti divora, non lo fa con i fuochi d’artificio. Lo fa in silenzio, a piccole dosi: una stanchezza che non passa, un sorriso che diventa maschera, una preghiera che si fa fatica, una Messa che non è più casa ma prestazione. Una solitudine che, a volte, porta a scelte irrimediabili – e qui il pensiero corre inevitabilmente a don Matteo.
A questo punto non ho risposte facili, e non voglio far finta di averle. Però una cosa la so: il Vangelo non manda mai nessuno da solo. Gesù manda “a due a due” e aggiunge “come pecore in mezzo ai lupi”, consapevole dell’enorme peso specifico di questo prezioso ministero. Li manda a due a due non per strategia organizzativa, ma perché l’annuncio senza compagnia diventa eroismo. E l’eroismo, nella vita spirituale, è spesso il nome elegante della solitudine. Forse è questo che dovremmo imparare: non c’è scandalo nel vedere un prete come un uomo. Lo scandalo vero è lasciare un uomo da solo.
La scelta non è un manifesto contro il sacerdozio; è un libro che mette in scena una domanda: mi è concesso essere prete restando fragile, imperfetto, incompiuto? «Il mio dubbio è: mi è permesso esserlo?» Domanda enorme, perché non riguarda solo Ravagnani. Riguarda la Chiesa che verrà: una Chiesa che o impara a distinguere tra fedeltà e rigidità, oppure continuerà a perdere pezzi — non solo “numeri”, ma coscienze. E allora, se devo dire perché un pezzo su Ravagnani vale la pena, non è per il personaggio mediatico. È perché il suo racconto è un sismografo: registra scosse che alcuni, o molti, vivono in silenzio. E, in certi casi, il silenzio non è prudenza: è un modo elegante di lasciare che la frattura diventi irreparabile.
C’è una frase che torna, quando un prete decide di non essere più soltanto “un prete”: “Ragazzi, vi devo parlare.” È la frase che apre una porta e, insieme, fa tremare le pareti. Perché quel “vi devo parlare” non è mai solo comunicazione: è una consegna. È un uomo che, finalmente, smette di reggere da solo un’immagine. Nel libro La scelta, Don Alberto Ravagnani racconta anche questo: il momento in cui l’apparato non basta più a contenere la vita. E lo dice in modo spietatamente semplice: «Questi paramenti non riescono più a contenere la mia umanità. Questo ruolo non riesce più a portare la mia fede». Non è una polemica contro la Chiesa in quanto tale; è un referto clinico su una frattura interna. Quando la forma non regge più il contenuto, la forma diventa gabbia. E, prima o poi, o si rompe la gabbia o si rompe l’uomo. Il punto, però, è che la crisi di Ravagnani non si presenta con l’estetica “da crisi”: niente abisso romantico, niente poesia facile. Anzi: l’apertura del libro è quasi da thriller, con le campane che esplodono e l’ansia che ti afferra per il collo: «Cazzo, la Messa!». Un incipit brutale perché è quotidiano. È lì che capisci la natura del problema: non stiamo parlando di un’idea, stiamo parlando di una vita concreta che inciampa su un dovere sacro, e di un sacro che non riesce più a essere casa.

Il cuore del libro, però, non è la polemica. È la solitudine. Ed è qui che mi sono sentito vicino all’ex presbitero. Non la solitudine “romantica”, ma quella strutturale: la solitudine di chi deve essere sempre all’altezza di un ruolo e, nel frattempo, resta un uomo. Ravagnani accenna a questo con un tono quasi paterno quando dice che, per molti, «diventare preti per sempre» spaventa. Quella formula è splendida in teologia e difficile nella psiche. Quando la comprendi fino in fondo ti fa paura. Perché il vincolo del matrimonio, per quanto totale, è “finché morte non vi separi”; l’ordinazione porta addosso la grammatica dell’assoluto: «Il Signore ha giurato e non si pente: “Tu sei sacerdote per sempre secondo l’ordine di Melchìsedek”» (Sal 110,4). La promessa è assoluta, mentre la persona è un continuo divenire, come un fiume che scorre nel suo letto. E quando il divenire viene trattato come infedeltà, allora la crisi non trova luoghi dove respirare. Qui non sono riuscito a leggere questa storia in maniera distaccata, algida, cronistica. Ho sentito risonanze troppo vicine per trattare tutto come una notizia. Venerdì sera le lacrime mi hanno solcato il viso: non per una “celebrità” dei social, ma per un uomo. Perché dietro questa storia, prima del clamore e dopo il clamore, resta sempre la stessa domanda nuda: è possibile essere prete senza smettere di essere umano?

Sì, è possibile. Ma non da soli. E questa è la parte che fa più male, perché nel modello che abbiamo ereditato la solitudine è spesso presentata come un prezzo “normale”, quasi un pedaggio inevitabile della vocazione. Ravagnani, invece, la chiama per quello che è: non un accessorio, ma un rischio. Un rischio spirituale e umano insieme. Nel libro, a un certo punto, il discorso scivola su una cosa che nella pratica ecclesiastica viene sempre evocata e raramente costruita: l’amicizia tra preti. Non la cordialità, non la fraternità da foto di gruppo, ma l’amicizia vera, quella che regge il peso dei giorni storti. E lì arriva una frase che, detta da un presbitero, suona come una diagnosi: siamo troppo preti per essere amici. Troppo identificati nel ruolo per permetterci la reciprocità, l’autenticità, perfino il diritto di non essere sempre “all’altezza”. Perché il punto non è avere gente attorno. Il punto è poter essere visti. E essere visti non come funzione, non come “don”, non come immagine pubblica da difendere, ma come persona. Quando il ruolo diventa totalizzante, qualunque cedimento ti appare come tradimento; qualunque fragilità, come scandalo; qualunque stanchezza, come colpa. A quel punto non sei più un uomo che prega: sei un uomo che si controlla. E un uomo che si controlla troppo, prima o poi, implode.
E allora la domanda cambia leggermente forma. Non è più solo: “posso essere prete senza smettere di essere umano?”. Diventa: “chi mi permette di restare umano mentre sono prete?”. Chi mi lascia spazio per avere paura senza essere giudicato? Chi mi ascolta senza trasformare tutto in pratica da archivio? Chi mi sta accanto senza chiedermi di essere, sempre e comunque, un esempio?
Se vogliamo essere onesti, la questione non riguarda soltanto Ravagnani. Riguarda un modo di intendere il ministero. Un sistema che chiede molto e, a volte, accompagna poco. E per questo la storia, letta dentro la categoria della solitudine, smette di essere un caso mediatico e diventa un avvertimento ecclesiale. Perché la solitudine non è neutra: o la attraversi con relazioni vere, oppure ti divora. E quando ti divora, non lo fa con i fuochi d’artificio. Lo fa in silenzio, a piccole dosi: una stanchezza che non passa, un sorriso che diventa maschera, una preghiera che si fa fatica, una Messa che non è più casa ma prestazione. Una solitudine che, a volte, porta a scelte irrimediabili – e qui il pensiero corre inevitabilmente a don Matteo.
A questo punto non ho risposte facili, e non voglio far finta di averle. Però una cosa la so: il Vangelo non manda mai nessuno da solo. Gesù manda “a due a due” e aggiunge “come pecore in mezzo ai lupi”, consapevole dell’enorme peso specifico di questo prezioso ministero. Li manda a due a due non per strategia organizzativa, ma perché l’annuncio senza compagnia diventa eroismo. E l’eroismo, nella vita spirituale, è spesso il nome elegante della solitudine. Forse è questo che dovremmo imparare: non c’è scandalo nel vedere un prete come un uomo. Lo scandalo vero è lasciare un uomo da solo.
La scelta non è un manifesto contro il sacerdozio; è un libro che mette in scena una domanda: mi è concesso essere prete restando fragile, imperfetto, incompiuto? «Il mio dubbio è: mi è permesso esserlo?» Domanda enorme, perché non riguarda solo Ravagnani. Riguarda la Chiesa che verrà: una Chiesa che o impara a distinguere tra fedeltà e rigidità, oppure continuerà a perdere pezzi — non solo “numeri”, ma coscienze. E allora, se devo dire perché un pezzo su Ravagnani vale la pena, non è per il personaggio mediatico. È perché il suo racconto è un sismografo: registra scosse che alcuni, o molti, vivono in silenzio. E, in certi casi, il silenzio non è prudenza: è un modo elegante di lasciare che la frattura diventi irreparabile.
Rubrica a cura di Pietro Santoro