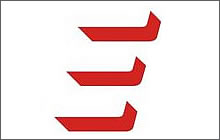Church Pocket/95. Seguire la coscienza senza legge, ma verso dove?
Dalla coscienza morale alla sua dissoluzione
Alcune notizie passano come passano tutte le notizie importanti: veloce, rumorosa, già stantia. E a volte ritornano alla ribalta vocaboli come “morale”. Si parla di bene e di male, di scelte inevitabili, di interventi “necessari”. Arrivano anche dai palazzi del potere, perché tanto uno vale l’altro. La reazione è prevedibile. Un misto di fastidio e rassegnazione. La morale usata come giustificazione elegante. Dio evocato senza essere mai chiamato in causa. Il bene che arriva sempre dopo la decisione, mai prima. Eppure il problema non è questo teatrino. Il problema è che quelle parole, ormai, non mordono più. Bene. Male. Giusto. Ingiusto. Le ascoltiamo come si ascolta una lingua straniera studiata male: riconosciamo i suoni, ma non ne sentiamo il peso. Non obbligano. Non vincolano. Non giudicano. Scivolano addosso con una facilità imbarazzante. Forse perché, prima ancora che nei palazzi del potere, le abbiamo svuotate nel vivere quotidiano. C’è una parola che oggi mette tutti d’accordo. È una parola che non si discute, non si contesta, non si problematizza: coscienza. La si cita con rispetto, quasi con devozione. “Bisogna seguire la propria coscienza”. “La coscienza va sempre rispettata”. Frasi vere ma incomplete. E quando una verità è monca, diventa pericolosa. Quindi diventa necessario capire il pensiero, teologico e filosofico, che ha arricchito il significato di certe parole.

Per Tommaso d'Aquino, la coscienza non è mai una voce autonoma. Non crea il bene, non lo inventa, non lo decide. La coscienza applica. È il luogo in cui la legge morale — che precede l’uomo — viene riconosciuta e assunta. Se sbaglia, non è perché è libera, ma perché è mal formata. E una coscienza mal formata non è un diritto da difendere, ma un problema da affrontare. Molti secoli dopo, Immanuel Kant sposterà l’asse. La coscienza diventa tribunale interiore, istanza ultima, dovere che obbliga senza appello. Ma anche qui non c’è spazio per il capriccio. La coscienza kantiana non consola, non giustifica, non accompagna: comanda. E giudica senza sconti. Due visioni diverse, ma entrambe lontanissime dall’idea oggi dominante di coscienza come zona protetta, rifugio soggettivo, alibi elegante per restare come si è. Il punto non è mettere insieme Tommaso e Kant come se dicessero la stessa cosa. Non la dicono. Ma su un aspetto decisivo si incontrano: la coscienza non è mai un rifugio soggettivo. Non nasce dal sentimento, non si giustifica da sola, non assolve per definizione. In entrambi i casi, l’uomo è messo davanti a qualcosa che lo precede e lo giudica. È esattamente questo il punto che Benedetto XVI ha cercato di salvare, quando parlava di relativismo. Non per nostalgia dottrinale, ma per una ragione più profonda: senza una verità che interpella, la coscienza non libera più. Si dissolve. Per Benedetto, il problema del nostro tempo non è l’eccesso di norme, ma l’assenza di un riferimento condiviso al vero e al bene. Quando la coscienza viene separata dalla verità, non diventa più responsabile: diventa autoreferenziale. In questo senso, paradossalmente, la coscienza moderna non è troppo “kantiana”. È sicuramente post-kantiana e post novecento. Ha tenuto l’idea del tribunale interiore, ma ne ha tolto la legge. Ha conservato il linguaggio del dovere, ma ha eliminato ciò che “obbliga” davvero. È rimasto solo il soggetto, chiamato giudice e imputato allo stesso tempo. È qui che Benedetto rompe l’equilibrio fragile del discorso contemporaneo. Per lui la coscienza non è né un’eco emotiva né una sovranità assoluta. È il luogo in cui l’uomo si scopre chiamato dalla verità. E una verità che non interpella più non è misericordia ma indifferenza. Il relativismo nel pensiero ratzingeriano non alza mai la voce ma si insinua, con parole educate e pacate. Dice che non è il momento, che la realtà è complessa, che ogni caso è diverso. Il risultato è una coscienza difesa a parole e abbandonata nei fatti. Una morale ridotta a linguaggio condivisibile e inclusivista, purché non chieda nulla e non urti la sfera del mio io. In questo orizzonte la coscienza non viene più educata, ma rassicurata, protetta, addomesticata e mai veramente interrogata. Il relativismo europeo - o più in generale, occidentale – non perseguita la coscienza, la addormenta. E una coscienza addormentata non fa rumore. Rimettere la coscienza davanti a Dio non è un atto nostalgico, devozionale o anacronistico. Significa restituirle una voce che non controlla, una misura che non decide, un giudizio che non addomestica. Significa accettare che il bene non sia negoziabile e che la verità non chieda il permesso. Senza questo, continueremo a parlare di morale e coscienza come si parla di tutto il resto: con parole educate, pensieri cauti e scelte già scritte. E la coscienza, ancora una volta, resterà sola, tranquilla. E irrimediabilmente inutile.
Il punto non è mettere insieme Tommaso e Kant come se dicessero la stessa cosa. Non la dicono. Ma su un aspetto decisivo si incontrano: la coscienza non è mai un rifugio soggettivo. Non nasce dal sentimento, non si giustifica da sola, non assolve per definizione. In entrambi i casi, l’uomo è messo davanti a qualcosa che lo precede e lo giudica. È esattamente questo il punto che Benedetto XVI ha cercato di salvare, quando parlava di relativismo. Non per nostalgia dottrinale, ma per una ragione più profonda: senza una verità che interpella, la coscienza non libera più. Si dissolve. Per Benedetto, il problema del nostro tempo non è l’eccesso di norme, ma l’assenza di un riferimento condiviso al vero e al bene. Quando la coscienza viene separata dalla verità, non diventa più responsabile: diventa autoreferenziale. In questo senso, paradossalmente, la coscienza moderna non è troppo “kantiana”. È sicuramente post-kantiana e post novecento. Ha tenuto l’idea del tribunale interiore, ma ne ha tolto la legge. Ha conservato il linguaggio del dovere, ma ha eliminato ciò che “obbliga” davvero. È rimasto solo il soggetto, chiamato giudice e imputato allo stesso tempo. È qui che Benedetto rompe l’equilibrio fragile del discorso contemporaneo. Per lui la coscienza non è né un’eco emotiva né una sovranità assoluta. È il luogo in cui l’uomo si scopre chiamato dalla verità. E una verità che non interpella più non è misericordia ma indifferenza. Il relativismo nel pensiero ratzingeriano non alza mai la voce ma si insinua, con parole educate e pacate. Dice che non è il momento, che la realtà è complessa, che ogni caso è diverso. Il risultato è una coscienza difesa a parole e abbandonata nei fatti. Una morale ridotta a linguaggio condivisibile e inclusivista, purché non chieda nulla e non urti la sfera del mio io. In questo orizzonte la coscienza non viene più educata, ma rassicurata, protetta, addomesticata e mai veramente interrogata. Il relativismo europeo - o più in generale, occidentale – non perseguita la coscienza, la addormenta. E una coscienza addormentata non fa rumore. Rimettere la coscienza davanti a Dio non è un atto nostalgico, devozionale o anacronistico. Significa restituirle una voce che non controlla, una misura che non decide, un giudizio che non addomestica. Significa accettare che il bene non sia negoziabile e che la verità non chieda il permesso. Senza questo, continueremo a parlare di morale e coscienza come si parla di tutto il resto: con parole educate, pensieri cauti e scelte già scritte. E la coscienza, ancora una volta, resterà sola, tranquilla. E irrimediabilmente inutile.
Alcune notizie passano come passano tutte le notizie importanti: veloce, rumorosa, già stantia. E a volte ritornano alla ribalta vocaboli come “morale”. Si parla di bene e di male, di scelte inevitabili, di interventi “necessari”. Arrivano anche dai palazzi del potere, perché tanto uno vale l’altro. La reazione è prevedibile. Un misto di fastidio e rassegnazione. La morale usata come giustificazione elegante. Dio evocato senza essere mai chiamato in causa. Il bene che arriva sempre dopo la decisione, mai prima. Eppure il problema non è questo teatrino. Il problema è che quelle parole, ormai, non mordono più. Bene. Male. Giusto. Ingiusto. Le ascoltiamo come si ascolta una lingua straniera studiata male: riconosciamo i suoni, ma non ne sentiamo il peso. Non obbligano. Non vincolano. Non giudicano. Scivolano addosso con una facilità imbarazzante. Forse perché, prima ancora che nei palazzi del potere, le abbiamo svuotate nel vivere quotidiano. C’è una parola che oggi mette tutti d’accordo. È una parola che non si discute, non si contesta, non si problematizza: coscienza. La si cita con rispetto, quasi con devozione. “Bisogna seguire la propria coscienza”. “La coscienza va sempre rispettata”. Frasi vere ma incomplete. E quando una verità è monca, diventa pericolosa. Quindi diventa necessario capire il pensiero, teologico e filosofico, che ha arricchito il significato di certe parole.

Per Tommaso d'Aquino, la coscienza non è mai una voce autonoma. Non crea il bene, non lo inventa, non lo decide. La coscienza applica. È il luogo in cui la legge morale — che precede l’uomo — viene riconosciuta e assunta. Se sbaglia, non è perché è libera, ma perché è mal formata. E una coscienza mal formata non è un diritto da difendere, ma un problema da affrontare. Molti secoli dopo, Immanuel Kant sposterà l’asse. La coscienza diventa tribunale interiore, istanza ultima, dovere che obbliga senza appello. Ma anche qui non c’è spazio per il capriccio. La coscienza kantiana non consola, non giustifica, non accompagna: comanda. E giudica senza sconti. Due visioni diverse, ma entrambe lontanissime dall’idea oggi dominante di coscienza come zona protetta, rifugio soggettivo, alibi elegante per restare come si è.

Rubrica a cura di Pietro Santoro