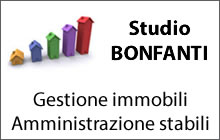Robbiate: le 'buone' dittature di Roma che salvavano le crisi, l'analisi della prof Biscotti
In quale misura la crisi istituzionale e politica dei nostri tempi riuscirà a sovvertire il nostro mondo, i nostri futuri? E' partito da una domanda molto simile a questa l'incontro organizzato dall'associazione ''CambiaMenti'' a Robbiate, nella serata di domenica 15 aprile, e da almeno una considerazione: conoscere un passato come quello dei Romani, che si scopre non essere poi così remoto, potrà aiutarci a comprendere meglio la situazione in cui ci troviamo, e perché no, aiutarci a cambiarla.
Perciò gli studenti dell'associazione hanno pensato bene di invitare nella sala consigliare robbiatese la professoressa Barbara Biscotti, docente di storia di diritto romano dell'Università Bicocca. Una giurista che, ha spiegato, ama ''partire dall'origine delle parole per comprendere il loro peso e ciò che comportano''. Le parole chiave di domenica sera sono state sostanzialmente tre: istituzione, crisi e dittatura. ''Sono una storica del diritto dell'antichità, una storica convinta, e convinta anche che una società che non si interroga sul proprio passato sia una società che rispecchia il famoso smemorato di Collegno, una società che non sa chi è - ha esordito la docente - Dico spesso ai miei studenti che ci sentiamo così moderni da non considerare di essere, in fondo, una conseguenza dell'antichità romana, il frutto delle esperienze passate''. Perciò, di fronte ad un quesito come quello che ha innescato la serata, non si può far altro che guardarsi alle spalle. Partendo, appunto, dalle origini, anche delle parole. ''Cosa è una crisi? Tendiamo sempre ad utilizzare questo termine come connotato negativo - ha spiegato la prof Biscotti - A prescindere da come la si vuole vedere, la crisi è eccezionalità, qualcosa che esce dall'ordinario, qualcosa che può cambiare la mia vita. E inoltre è un'emergenza, un'alterazione di equilibri normali''.
VIDEO
La professoressa universitaria si è poi concentrata sul concetto di istituzione. ''A ben vedere, non esiste un'aggregazione di uomini che non equivalga ad una necessità di regole - ha spiegato - Nemmeno una relazione può prescindere dalle regole. Questo principio è l'embrione del diritto e della società. Da questo punto di vista il concetto di istituzione, quindi, è la traduzione di ciò che agisce nel mondo delle norme giuridiche, all'interno di una società''. Nell'immaginario collettivo, oltretutto, l'istituzione è diventata ormai qualcosa di estraneo, di calato dall'alto. Secondo la docente Biscotti, tuttavia, anche se la sensazione è diffusa, l'istituzione è tutt'altro. ''In quanto rispecchiamento delle regole che le persone si danno - ha spiegato - non è altro che la manifestazione della società stessa''.
Ci pensarono i romani, dunque, ad ''inventarsi'' i dictator. ''A partire dal 501 a.C. ci troviamo di fronte ad uno dei più grandi paradossi storici - ha proseguito la docente - La nascita della dittatura romana nasce infatti all'indomani della celebre cacciata dei re. Dopo aver mandato via Tarquinio il Superbo i romani giurarono che non avrebbero mai dato più il potere ad un solo uomo. Seguirono infatti i due consoli, che per un certo periodo garantiscono lo smezzamento del potere, in forma più equilibrata. Ciò avviene però nel 509 a.C., e solo otto anni più tardi gli stessi romani nominano un dittatore. A Roma, in quel tempo, imperversavano crisi esterne ed interne, e c'erano diverse minacce di guerra. Le istituzioni di allora furono perciò chiamati a gestire un caso di eccezionalità e di emergenza che i poteri ordinari (i due consoli) non erano in gradi di affrontare. Le assemblee del popolo scelsero quindi di istituire la figura del dittatore, dictator, con caratteristiche specifiche comunque diverse da quelle che consideriamo noi. Innanzitutto restavano in carica solo sei mesi e non avevano poteri generici ma dovevano far fronte all'emergenza delle guerre. Non potevano nemmeno montare a cavallo. E questo chiama in causa la simbologia e ci suggerisce quanto sia importante per l'umanità, come lo è ora. Il cavallo è infatti il simbolo del re, della monarchia, quella che i romano avevano appena scacciato''.

Perciò gli studenti dell'associazione hanno pensato bene di invitare nella sala consigliare robbiatese la professoressa Barbara Biscotti, docente di storia di diritto romano dell'Università Bicocca. Una giurista che, ha spiegato, ama ''partire dall'origine delle parole per comprendere il loro peso e ciò che comportano''. Le parole chiave di domenica sera sono state sostanzialmente tre: istituzione, crisi e dittatura. ''Sono una storica del diritto dell'antichità, una storica convinta, e convinta anche che una società che non si interroga sul proprio passato sia una società che rispecchia il famoso smemorato di Collegno, una società che non sa chi è - ha esordito la docente - Dico spesso ai miei studenti che ci sentiamo così moderni da non considerare di essere, in fondo, una conseguenza dell'antichità romana, il frutto delle esperienze passate''. Perciò, di fronte ad un quesito come quello che ha innescato la serata, non si può far altro che guardarsi alle spalle. Partendo, appunto, dalle origini, anche delle parole. ''Cosa è una crisi? Tendiamo sempre ad utilizzare questo termine come connotato negativo - ha spiegato la prof Biscotti - A prescindere da come la si vuole vedere, la crisi è eccezionalità, qualcosa che esce dall'ordinario, qualcosa che può cambiare la mia vita. E inoltre è un'emergenza, un'alterazione di equilibri normali''.
VIDEO
La professoressa universitaria si è poi concentrata sul concetto di istituzione. ''A ben vedere, non esiste un'aggregazione di uomini che non equivalga ad una necessità di regole - ha spiegato - Nemmeno una relazione può prescindere dalle regole. Questo principio è l'embrione del diritto e della società. Da questo punto di vista il concetto di istituzione, quindi, è la traduzione di ciò che agisce nel mondo delle norme giuridiche, all'interno di una società''. Nell'immaginario collettivo, oltretutto, l'istituzione è diventata ormai qualcosa di estraneo, di calato dall'alto. Secondo la docente Biscotti, tuttavia, anche se la sensazione è diffusa, l'istituzione è tutt'altro. ''In quanto rispecchiamento delle regole che le persone si danno - ha spiegato - non è altro che la manifestazione della società stessa''.

La robbiatese Eleonora, allieva della professoressa Barbara Biscotti, docente di storia di diritto romano, Università Bicocca, accanto a lei

Ci pensarono i romani, dunque, ad ''inventarsi'' i dictator. ''A partire dal 501 a.C. ci troviamo di fronte ad uno dei più grandi paradossi storici - ha proseguito la docente - La nascita della dittatura romana nasce infatti all'indomani della celebre cacciata dei re. Dopo aver mandato via Tarquinio il Superbo i romani giurarono che non avrebbero mai dato più il potere ad un solo uomo. Seguirono infatti i due consoli, che per un certo periodo garantiscono lo smezzamento del potere, in forma più equilibrata. Ciò avviene però nel 509 a.C., e solo otto anni più tardi gli stessi romani nominano un dittatore. A Roma, in quel tempo, imperversavano crisi esterne ed interne, e c'erano diverse minacce di guerra. Le istituzioni di allora furono perciò chiamati a gestire un caso di eccezionalità e di emergenza che i poteri ordinari (i due consoli) non erano in gradi di affrontare. Le assemblee del popolo scelsero quindi di istituire la figura del dittatore, dictator, con caratteristiche specifiche comunque diverse da quelle che consideriamo noi. Innanzitutto restavano in carica solo sei mesi e non avevano poteri generici ma dovevano far fronte all'emergenza delle guerre. Non potevano nemmeno montare a cavallo. E questo chiama in causa la simbologia e ci suggerisce quanto sia importante per l'umanità, come lo è ora. Il cavallo è infatti il simbolo del re, della monarchia, quella che i romano avevano appena scacciato''.

A.S.