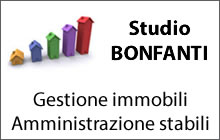Lunedì sera i posti a sedere dell'Aula Magna degli Istituti Agnesi e Viganò di Merate sono stati occupati fino all'ultimo dalle tante persone intervenute per ascoltare la lezione del filosofo Salvatore Natoli - professore ordinario di filosofia teoretica presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - sul tema della 'spiritualità nel fine vita'. Promosso dal gruppo culturale La Semina e dall'Associazione Fabio Sassi onlus l'incontro è stato moderato dal dottor Mauro Marinari, direttore sanitario dell'hospice 'Il Nespolo' di Airuno. Per una introduzione alla figura del professor Salvatore Natoli rimandiamo alla pagina di Wikipedia a lui dedicata, dove è possibile trovare la bibliografia completa del filosofo: http://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Natoli. Per quanto concerne il tema della serata segnaliamo in particolare l'opera "
Le parole ultime. Dialogo sui problemi del «fine vita» (Nuova biblioteca Dedalo, 2011).

Il prof. Salvatore Natoli
- ha spiegato il filosofo -
Tutti moriamo, ma lo facciamo in modo differente. Perché diverse sono le concezioni della morte, a partire da come si intende rispondere a due domande: perché si muore? Cosa c'è dopo? La concezione cristiana - oggi al tramonto - ha sempre inteso la morte non come 'fine dell'esistenza', ma come passaggio, in attesa delle resurrezione della carne. Ma credo che poche persone delle centinaia presenti in questa sala stasera possano dire di credere nel loro cuore, nella loro mente, a una tale concezione della morte. E' più probabile che parlando di 'resurrezione della carne' ci si dica 'ma com'è possibile che si sia creduto a questo genere di follie?'. Eppure ci sono state epoche storiche in cui si è creduto, e fortemente, a tale concezione. E altre ancora dove la morte è stata considerata un evento naturale - della natura che non si rattrista - da inserire senza scandalo nel più vasto ciclo di trasformazioni dell'Essere. Ai giorni nostri sembra che la morte arrivi da fuori, come un accidente imprevisto. E' difficile che si consideri la morte come qualcosa che ci matura dentro nel corso stesso della vita. Ognuno di noi è vita e morte insieme. Il movimento della vita contiene in sé la stessa morte. I greci avevano due parole per indicare la vita: zoé, (vita nel suo insieme, physis indifferenziata, natura) e bios, (vita singola, determinata, unica). Con la nascita il bios emerge come coscienza dal grande movimento della zoé e vi ritorna con la morte. Nella concezione greca il bios non è che una 'variazione di ritmo' nel grande movimento della zoé, dove la morte non stupisce, e dove il cadavere, deposto nella terra, si trasforma in seme, in germe di vita nuova per la zoé. Nei tempi passati la morte poteva essere dolorosa, ma si esauriva nel grido lancinante del morente. Ricordiamo le parole di Epicuro: 'I mali se affliggono duramente affliggono per poco, altrimenti se lo fanno a lungo vuol dire che si possono sopportare'. Ma oggi la tecnica, la medicina preventiva e quella curativa, hanno fatto sì che anche un grave patimento possa essere prolungato per un tempo indefinito, esacerbando la sofferenza mentale, ovvero l'atroce consapevolezza del malato che può assistere minuto per minuto al suo progressivo disfacimento. Il corpo sano sente il mondo, il corpo malato sente il corpo. La prospettiva di vita è cresciuta perché è migliorata la nostra costituzione, grazie alla prevenzione. La nostra vita è meglio costituita e meglio custodita. Ma come si muore oggi?".

Da sinistra il filosofo Salvatore Natoli, la direttrice del Liceo
Agnesi Maria Teresa Rigato e il direttore sanitario
dell'hospice il Nespolo Dr Mauro Marinari
Nella disamina del professor Natoli la società contemporanea viene descritta nelle proprie contraddizioni, nelle proprie
impasse: aumento della prospettiva di vita, gestione della vecchiaia affidata a soggetti esterni alla famiglia (badanti), gestione del fine vita ad ambienti ospedalieri medicalizzati, spesso nella solitudine e nel completo oblìo della soggettività del morente, trattato come 'caso'.
"Ai tempi delle famiglie 'claniche' - ha continuato il filosofo -
cugini, zii, madri e fratelli assistevano il morente al momento del trapasso. Se non per affetto, lo facevano almeno per 'funzione'. Oggi la società è atomizzata, la famiglia conta pochi elementi e i figli viaggiano, si spostano lontano, e quando una persona perde - anche solo in parte - la propria autosufficienza viene affidata alle cure di una persona estranea, pagata. Dove la funzione di accudimento della famiglia latita deve essere la società nel suo insieme, al di là dei legami di sangue, a prendersi cura dei propri membri nel momento del fine vita. E qui scatta la funzione innovativa dell'hospice, quando riesce ad essere un luogo dove la relazionalità viene conservata fino alla fine, dove il malato terminale viene investito di una responsabilità relazionale che potrebbe dare senso anche ai suoi ultimi momenti. Spesso il malato terminale sente vicina la fine, l'avverte come una risoluzione, un sollievo per sé e per le persone intorno a lui a cui sente di stare infliggendo una forte sofferenza. La parola che conta è certamente quella del sofferente, ma occorre ricordare che la dimensione sociale della malattia può significativamente influenzare le scelte di chi si trova vicino alla fine. Chi sta per morire si trova in una condizione molto lontana da quella di chi ''non-malato' si percepisce come 'non-mortale', e potrebbe per ciò avere molto da dire, da insegnare, a chi fosse capace di ascolto empatico". In questo senso nell'ultima parte il discorso di Salvatore Natoli è sembrato rivolgersi ancor più da vicino ai tanti operatori e volontari dell'hospice 'Il Nespolo' di Airuno presenti in sala. Il filosofo siciliano ha fatto riferimento a illuminanti conversazioni tra morenti/maestri e curanti:
"Ma perché un morente possa 'seminare vita' tramite la testimonianza della propria storia di uomo occorre che ci siano 'discepoli' disposti ad ascoltarlo. Con rispetto. Con gratuità. Con quella Caritas che è forse l'ultimo autentico lascito della tradizione cristiana. E' una Caritas collettiva che deve fiorire. E' la società nel suo insieme che deve prendersi carico di chi soffre. Non per sentimentalismo, ma per dovere. Non può esserci spazio per il patetico, per il 'poveretto, mi fa pena'. In questo ambito non serve l'amore fine a sé stesso, ma il dovere. Ho il dovere di amare. Non a caso nel cristianesimo quella dell'Amore è una Legge, non una simpatia. Alla vita eterna non crede più nessuno, alla resurrezione della carne meno che mai. A Dio? Forse... Il 'farsi prossimo gli uni degli altri', ecco cosa ci rimane. E non c'è bisogno di vescovi, di papi o di preti. Basta Cristo. O Buddha... Il grande sentimento orientale della compassione, in quanto siamo tutti momento e parte della stessa physis... Solo incrociando la tecnica con questa etica generale della società, con questo farsi carico della fragilità umana, solo in questo modo le persone, tutte destinate a morire, riterranno opportuno vivere il più a lungo possibile, non fosse altro che per seminare vita attraverso la loro stessa morte".
Massimo Colombo