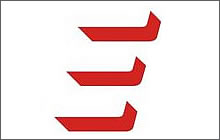Qualche "ma" per la grande tragedia di Crans Montana
Mi hanno chiesto in tanti di scrivere un commento sulla tragedia di Crans Montana e con molti ho glissato con parole di circostanza. Capisco che, quando accadono fatti del genere, si voglia trovare un senso (e un colpevole), e mi rendo altrettanto conto che si sfoderino pareri anodini, per cautelarsi dietro il politicamente corretto ed evitare di parlare di pancia.
“Chi ha figli taccia”, diceva sempre la mia nonna, a insegnare prudenza a chi tranciava giudizi immediati sui figli degli altri, sicuro che ai propri, a lui, certe cose non sarebbero capitate!
“Sono tutti figli nostri”, scriveva ieri Ferruccio de Bortoli sul “Corriere della sera”, mentre oggi su “la Repubblica” Massimo Recalcati discetta da par suo sul lutto genitoriale citando Nanni Moretti, la pietas e altre amenità delle sue.

Ma ci sono un po’ di “ma”, contro la reticenza quasi scaramantica e umile del buon senso di mia nonna, contro la mielosità del direttore, e contro il filosofeggiare dello psicanalista, e si leggono in filigrana nella tribuna dei social, nei commenti netti e impopolari di chi ricorda come non troppi anni fa tutti noi a sedici anni festeggiassimo in oratorio, a casa di amici, con adulti partecipi e attenti, con pochi soldi a disposizione, senza alcuna necessità di eccessi o di puntate in località oltreconfine dove la soglia di accesso al consumo di alcolici non è posta a diciott’anni, come in Italia, ma a sedici. Si legge quasi un atto di accusa nei confronti di chi, invece che fuggire subito, ha perso tempo a filmare gli attimi iniziali dell’incendio con il proprio smartphone, e dei padri che appaiono davanti a selve di microfoni per raccontare il proprio dolore o il proprio sollievo.
C’è uno scuotimento di teste silenziose fatto di pragmatismo e rassegnazione negli adulti che incrocio dalla formaggiaia e dal prestinaio: “Mi, cunt ’l me bagaj semm andàa a durmi alla svèlta perché incòo sem andàa su cunt i pell” (Io e mio figlio siamo andati a dormire presto perché oggi siamo saliti con le pelli [gli sci d’alpinismo]), mormora uno, quasi vergognandosi della semplicità rude. “Anche mio figlio ha sedici anni, e abbiamo fatto la fiaccolata con le torce, poi un bicchierino di vin brulè ma giusto il profumo, perché ha solo sedici anni…”, dice un altro.
Forse è perché trascorro questi giorni a cavallo del nuovo anno in una località di montagna selvaggia, di quelle in cui non ci sono discoteche ma rifugi, non ci sono funivie ma sentieri, la neve si accoglie e non si spara, come i botti, men che meno al chiuso, ma sono queste le voci miti che ascolto e che sento parlare anche in me.
Sarebbe troppo comodo leggerci in filigrana un atto d’accusa inespresso nei confronti di stili di festa artificiali, avallati da famiglie che ora piangono figli solo adolescenti di cui hanno riempito i portafogli (perché la fiaccolata sulle piste di Chiesa in Valmalenco, dove sono io, costava 20 euro, l’ingresso al locale esclusivo un pochino in più, temo), ma – e questo è l’articolo dei “ma” – la catena delle responsabilità per la tragedia di Crans Montana non può ridursi all’ultimo anello del materiale fonoassorbente forse non ignifugo, o a quegli sconclusionati che hanno preso in braccio una ragazza con due bottiglie di champagne e annessa fontanella pirotecnica (praticamente una molotov ma più da fighetti milanesi che da terroristi) avvicinandola a tanto così dal soffitto che poi ha preso fuoco.
Ma mi rendo conto di apparire moralista se scrivo che stili di vita esaltati forse non determinano ma sicuramente espongono a rischi come questo di Crans Montana.
Ma mentre risalgo a fatica coi ramponi su un sentiero ghiacciato e infido, dietro mio figlio sedicenne che batte la traccia, mi rendo conto che crescere un figlio costa enorme fatica, alimenta quotidiane paure, chiama in causa enormi dubbi ed è, perlopiù, un dono più che una capacità. Ma le fatalità – tranne rarissimi e terribili casi (per chi volesse accusarmi di insensibilità: ho perso anche io una figlia qualche anno fa) – non esistono, e ho il dubbio che le responsabilità siano sempre, anzitutto, educative.
La mia povera nonna disapproverebbe, lo so. Ma ormai l’ho scritto.
“Chi ha figli taccia”, diceva sempre la mia nonna, a insegnare prudenza a chi tranciava giudizi immediati sui figli degli altri, sicuro che ai propri, a lui, certe cose non sarebbero capitate!
“Sono tutti figli nostri”, scriveva ieri Ferruccio de Bortoli sul “Corriere della sera”, mentre oggi su “la Repubblica” Massimo Recalcati discetta da par suo sul lutto genitoriale citando Nanni Moretti, la pietas e altre amenità delle sue.

Ma ci sono un po’ di “ma”, contro la reticenza quasi scaramantica e umile del buon senso di mia nonna, contro la mielosità del direttore, e contro il filosofeggiare dello psicanalista, e si leggono in filigrana nella tribuna dei social, nei commenti netti e impopolari di chi ricorda come non troppi anni fa tutti noi a sedici anni festeggiassimo in oratorio, a casa di amici, con adulti partecipi e attenti, con pochi soldi a disposizione, senza alcuna necessità di eccessi o di puntate in località oltreconfine dove la soglia di accesso al consumo di alcolici non è posta a diciott’anni, come in Italia, ma a sedici. Si legge quasi un atto di accusa nei confronti di chi, invece che fuggire subito, ha perso tempo a filmare gli attimi iniziali dell’incendio con il proprio smartphone, e dei padri che appaiono davanti a selve di microfoni per raccontare il proprio dolore o il proprio sollievo.
C’è uno scuotimento di teste silenziose fatto di pragmatismo e rassegnazione negli adulti che incrocio dalla formaggiaia e dal prestinaio: “Mi, cunt ’l me bagaj semm andàa a durmi alla svèlta perché incòo sem andàa su cunt i pell” (Io e mio figlio siamo andati a dormire presto perché oggi siamo saliti con le pelli [gli sci d’alpinismo]), mormora uno, quasi vergognandosi della semplicità rude. “Anche mio figlio ha sedici anni, e abbiamo fatto la fiaccolata con le torce, poi un bicchierino di vin brulè ma giusto il profumo, perché ha solo sedici anni…”, dice un altro.
Forse è perché trascorro questi giorni a cavallo del nuovo anno in una località di montagna selvaggia, di quelle in cui non ci sono discoteche ma rifugi, non ci sono funivie ma sentieri, la neve si accoglie e non si spara, come i botti, men che meno al chiuso, ma sono queste le voci miti che ascolto e che sento parlare anche in me.
Sarebbe troppo comodo leggerci in filigrana un atto d’accusa inespresso nei confronti di stili di festa artificiali, avallati da famiglie che ora piangono figli solo adolescenti di cui hanno riempito i portafogli (perché la fiaccolata sulle piste di Chiesa in Valmalenco, dove sono io, costava 20 euro, l’ingresso al locale esclusivo un pochino in più, temo), ma – e questo è l’articolo dei “ma” – la catena delle responsabilità per la tragedia di Crans Montana non può ridursi all’ultimo anello del materiale fonoassorbente forse non ignifugo, o a quegli sconclusionati che hanno preso in braccio una ragazza con due bottiglie di champagne e annessa fontanella pirotecnica (praticamente una molotov ma più da fighetti milanesi che da terroristi) avvicinandola a tanto così dal soffitto che poi ha preso fuoco.
Ma mi rendo conto di apparire moralista se scrivo che stili di vita esaltati forse non determinano ma sicuramente espongono a rischi come questo di Crans Montana.
Ma mentre risalgo a fatica coi ramponi su un sentiero ghiacciato e infido, dietro mio figlio sedicenne che batte la traccia, mi rendo conto che crescere un figlio costa enorme fatica, alimenta quotidiane paure, chiama in causa enormi dubbi ed è, perlopiù, un dono più che una capacità. Ma le fatalità – tranne rarissimi e terribili casi (per chi volesse accusarmi di insensibilità: ho perso anche io una figlia qualche anno fa) – non esistono, e ho il dubbio che le responsabilità siano sempre, anzitutto, educative.
La mia povera nonna disapproverebbe, lo so. Ma ormai l’ho scritto.
Stefano Motta